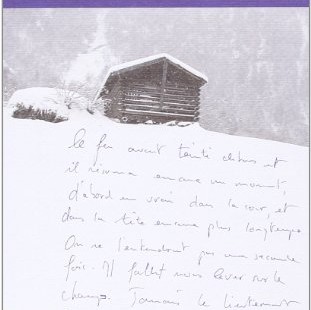
“Un pasto in inverno” di Hubert Mingarelli
Recensione di “Un pasto in inverno” (Nutrimenti 2014) di Hubert Mingarelli.
“Un pasto in inverno” è il racconto di un marcia nella neve, un tentativo di fuga dalla realtà: Partimmo all’alba, di fretta, prima della prima fucilazione, senza mangiare. La strada era più dura della pietra. Camminammo a lungo senza fermarci, nel freddo, sotto un cielo ghiacciato, ma un po’ felici, capite. (…) Andammo così lontano senza fermarci che non sentimmo niente, neanche l’eco della prima fucilata. Fu come se fossimo usciti da un posto che non ci piaceva.
È in corso un conflitto, ma non siamo sul fronte, a destreggiarci tra gli spari degli attacchi nemici, a dar prova di coraggio e valore salvando la vita dei propri compagni, il campo è una casa degli orrori dove la morte arriva con uno spietato calcolo.
Durante la Seconda Guerra Mondiale tre soldati tedeschi (Emmerich, Bauer e l’io narrante) chiedono il permesso di uscire, per un giorno, a caccia di ebrei, nella campagna polacca, per sottrarsi all’atrocità delle fucilazioni ai prigionieri inermi. Qui sorprendentemente trovano un giovane ebreo in una buca e lo catturano, poi preparano un pasto di fortuna in una casupola fatiscente in compagnia di un altro personaggio che appare nella storia: un polacco antisemita. Tutti e cinque si siederanno attorno a un tavolo a consumare un pranzo miracoloso, i cui ingredienti sembrano elementi di una pozione magica. Ma nessun incantesimo potrà sottrarli a un destino già segnato. Perché come dichiara l’autore in un’intervista, non si tratta di un “conte de fées” piuttosto di una “histoire réaliste”. Siedono al tavolo il terrore del ragazzo ebreo, la nostalgia dei tre boia e l’indifferenza del polacco.
L’atmosfera nel campo e successivamente in marcia è gelida e rarefatta quasi sospesa: il freddo è così intenso che congela i pensieri dei protagonisti. Da un lato è il nemico numero uno contro cui far fronte prima ancora della fame o degli spari perché minaccia costantemente la sopravvivenza; dall’altro il gelo attanaglia mente e cuore dei soldati che quasi non riescono a comunicare tra loro, come se persino i pensieri affiorando sulle labbra si congelassero. Non a caso il testo riecheggia di espressioni quali morire di freddo o crepare in piedi: la morte è sempre in agguato.
La neve, la nebbia, il cielo grigio contribuiscono a creare una sensazione di tempo indistinto e confuso: Una luce misera filtrava dalla finestra ricoperta di brina. Era tardo pomeriggio ma Emmerich pensò che fosse mattina. (…) Dato che non si vedeva niente a causa della brina continuò a cercare di sbrogliare la notte dal giorno. Diventa difficile distinguere il giorno dalla notte, la luce dall’oscurità e questa sensazione si trasmette metaforicamente all’eterno scontro tra il bene e il male. È il tempo delle tenebre e anche quando sorgerà, sarà un pallido sole a illuminare il loro cammino. Le efferatezze perpetrate in guerra sembrano cercare una giustificazione nella mancanza di qualsiasi riferimento, un caos di coordinate spazio-temporali.
Nonostante tutto fra i tre commilitoni si crea un certo affiatamento: la consapevolezza di condividere le stesse orrorifiche esperienze, li spinge a stringere un patto per resistere fino a un ritorno alla normalità. La normalità è immaginata, desiderata, agognata con tale intensità che si fa strada a diverse riprese nel testo. Dapprima emerge dal passato, sopravvive nella memoria come un tempo non lontano cronologicamente, ma remoto e nostalgico, quasi fiabesco. Oppure li abbaglia come un miraggio, dal momento che forse comprendono bene che pur sopravvivendo agli anni di guerra non potranno più tornare alle loro vite. Poi ci sono i sogni, frutti dell’inconscio, si pensi al sogno del narratore che richiama la vita civile con un giro in tram, tanto semplice ma per questo straordinario. Lì i sogni, belli o brutti che fossero, era meglio tenerseli per sé, infatti decidono per un tacito accordo di non raccontarli per non alimentare false speranze.
La paternità di Emmerich porta nella storia un quarto compagno di viaggio: il figlio di Emmerich adesso ci accompagnava. Il ragazzo non compare mai nel romanzo, neppure in un flashback, ma in una ricerca di normalità rappresenta la speranza di un futuro, la proiezione delle loro vite in un tempo successivo al conflitto. La proposta di concedere la libertà al prigioniero ebreo, appena catturato, arriva da Emmerich: sapevo chi, segretamente, Emmerich aveva visto nell’ebreo, e chi, quindi nella sua immaginazione, avremmo riportato al campo o lasciato andare. E così, adesso, potevo fargli del bene. Potevo dargli una mano, capire più che mai la sua inquietudine e l’amore per suo figlio, e togliergli un po’ di quell’inquietudine.
L’originalità del racconto risiede nella scelta del punto di vista, che è quello dei soldati tedeschi. In questo capovolgimento di prospettiva che disorienta il lettore, non a caso proprio gli occhi dei personaggi evidenziano una contrapposizione: gli occhi dei carnefici sono due buchi da cui penetra il freddo; gli occhi della vittima ebrea sono invece pieni di luce. Un’anima, un cuore che palpita, sotto la stratificazione di vestiti si contrappone alla vacuità di uno sguardo privo di umanità in cui si sprofonda nell’abisso insondabile del male.
