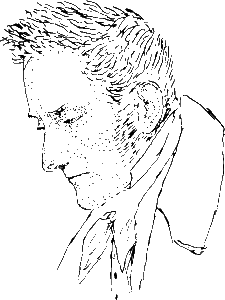Manzoni e la storia: le sabbie mobili della nevrosi
Il rapporto tra Manzoni e la storia, nel momento della nascita del romanzo.
Se ci venisse chiesto cosa abbia spinto il Manzoni, nell’aprile del 1821, a piantar lì la composizione di Adelchi, di cui del resto era ampiamente stufo, e che non riusciva ad andare oltre il terzo atto, per lanciarsi nell’avventura del nuovo, screditato genere del romanzo in prosa (perché non è affatto vero, come di solito si dice, che il romanzo in Italia a quell’epoca non esisteva: a parte l’ovvia eccezione dell’Ortis foscoliano, c’era stata, per tutto il Settecento, una più o meno sotterranea fioritura di romanzi, con centro di emanazione editoriale a Venezia; quello che è vero è che questi romanzi erano tutti, innegabilmente, abbastanza scadenti, sul piano, non si dice della letteratura, ma neanche di una minima decenza formale), le risposte verrebbero pronte, e perfino scontate: c’era, intanto, in quei primi due decenni dell’Ottocento, il furoreggiare, sui banchi dei librai – come quello davanti al quale Manzoni venne colto dalle convulsioni, alla notizia di Waterloo -, dei romanzi di Walter Scott.
E, in seconda istanza, più serio, in un intellettuale che era perfino genticamente – coi suoi, maledettamente impresentabili, 24 cromosomi Verri in aggiunta ai 24 Beccaria – predisposto al morbo illuministico dell’utile come scopo, magari anche l’intento di adoperare il “traliccio” di una vicenda romanzesca per veicolare, tra i meno fortunati culturalmente, contenuti patriotticamente e politicamente significativi (e anche qui, l’intuizione non era sua, ma della sfortunata intellettuale napoletana Eleonora de Fonseca, nei pochi mesi che durò la generosa, velleitaria Repubblica Partenopea: e può essergli arrivata, insieme al culto del Vico, dalla frequentazione milanese di Vincenzo Cuoco, autore poi di suo di un fallimentare Platone in Italia e legato, ad Eleonora, da una tempestosa e controversa liaison, fino al momento di fuggire da Napoli in Francia e poi a Milano, lasciandola alle forche del Nelson).
Già: ma perché proprio un romanzo storico? E storico, poi, con un tasso di così maniacale scrupolosità, e così miopemente fraintesa dai rilevi infastiditi di Goethe, anche lui – come già l’anonimo recensore del romanzo sulla rivista “Kunst und Altertum” che aveva aperto il libro convinto che lo scopo ne fosse “quello di rappresentare l’amore e le sofferenze di due fidanzati” e trovava insopportabile “accompagnare lo storico, là dove ci aspettavamo e ci auguravamo di essere condotti dal poeta” – impaziente di veder “tornare in campo i personaggi del romanzo” e sentirsene costretto “a tornare all’usuale ammirazione” per il loro autore.
Ebbene, una risposta abbastanza spiazzante, rispetto a quelle consolidate e quasi ovvie date fin qui, risulta invece quella suggerita dal recentissimo saggio di Paolo D’Angelo, Le nevrosi di Manzoni Quando la storia uccise la poesia (il Mulino, 2013): la scelta della Storia, come molto più di una scottiana intelaiatura del canovaccio – che del resto, poco che ci si pensi, rimanda ancora una volta agli archetipi dell’Illuminismo: Figaro a cui il feudatario prepotente insidia con scarso successo la promessa sposa, il giorno stesso delle nozze; o, con punti di contatto ancora più calzanti nel rapimento e nella prigionia della fidanzata, il Lessing di Emilia Galotti -, della Storia, si diceva, come ragion d’essere essenziale del libro, affonda, per D’Angelo, le sue radici nella psiche stessa dell’autore: nel grumo nero della sua nevrosi. Non è altro che un modo per sottrarsi all’ansia dello spazio totalmente aperto dell’invenzione assoluta, libera, prona ai più sfrenati esiti creativi; invenzione su cui, come del resto su quella del teatro, D’Angelo ricorda opportunamente, pesava, ora scandalizzata, sprezzante, ora oscuramente affascinata come le recriminazioni di sant’Agostino sulle lacrime versate in gioventù su Didone suicida per amore, la condanna della pubblicistica cattolica, i Nicole, i Bossuet, scoperti probabilmente dal Manzoni nel primo, giovanile soggiorno a Pargi (così, Ermengarda poi respirerà, inebriandosi, “le vivide / aure del Franco lido”), fino a mutuarne il più castrante ma rivelatore degli auto-divieti: quello per cui, proprio nel Fermo e Lucia, confessa: “Io sono del parere di coloro i quali dicono che non si deve scrivere d’amore in modo da far consentire l’animo di chi legge a questa passione” (ancora una volta, Ermengarda, nell’abbassarsi dei freni inibitori con il delirio: “Amor tremendo è il mio […] oh! tutto ancora / non tel mostrai […] nè tutta mai / questo labbro pudico osato avria / dirti l’ebbrezza del mio cor segreto”).
Dunque i fatti “veri”, già successi, in quell’unico modo, preciso e mai più mutabile, riusciranno a dare all’autore la sensazione di ciò che definiva lui stesso, in una lettera, il Festboden, il “terreno solido” (“fermo”, come il primo nome di Renzo?) su cui avanzare sicuro, libero da quella che, nella vita reale, era la più devastante delle sue nevrosi: l’agorafobia per cui vacillava e cedeva sulle gambe, a dover traversare uno spazio aperto, a meno che non ci fosse subito al suo fianco qualcuno di famiglia: si badi bene, non uno qualsiasi, un servitore, un estraneo, no, proprio uno di famiglia (un sostituto, forse, della mancante ombra paterna, già riconosciuta, con razionalistico sprezzo di ogni mormorazione meneghina, nell’Imbonati, al momento stesso di perderlo?); i fatti storici sono, per il Manzoni, questo braccio su cui sostenersi.
Ma, per restare alla metafora scelta da Manzoni stesso, il terreno apparentemente ben saldo della grande Storia, quel dominio della follia (o Napoleone non giungerebbe a “..un premio / ch’era follia sperar…”), in cui può darsi il “tristo, ma importante fenomeno” deplorato nel Discorso sovra alcuni punti dalla storia longobardica in Italia, di “un’immensa moltitudine di uomini, una serie di generazioni, che passa sulla terra, sulla sua terra, inosservata, senza lasciarvi traccia”, ebbene la Storia si dimostrò infinitamente più divorante di qualsiasi sabbia mobile, per lo scrittore Manzoni: e alla sistematica, quasi auto-punitiva, distruzione da parte del nevrotico Manzoni, non solo di qualsiasi possibilità di inventare un’altra trama romanzesca, ma anche semplicemente di intrecciarla a vicende storiche già date, D’Angelo dedica il corpo centrale del libro, imperniato su una illuminante lettura del saggio Del romanzo storico, e, in genere, de’ componimenti misti di storia e d’invenzione; opera lungamente meditata, pensata in origine come una lettera, sulla scia di quella allo Chauvet sulle unità “aristoteliche” della tragedia, in risposta proprio alle osservazioni critiche di Goethe (“una lettera, opuscolo, o che so io” aveva commentato Donna Giulia in una lettera del 1829, con la sua travolgente simpatia da Donna Prassede prodiga di strafalcioni ortografici), il Romanzo storico approdò, anni dopo la morte del dedicatario d’origine, alla più radicale sconfessione di qualsiasi commistione con la Storia “dell’inventato, che è quanto dire del falso”.
Ma, in realtà, sarebbe meglio dire che è l’intera l’opera del Manzoni, soprattutto del Manzoni prosatore teorico, ad essere scrutata da D’Angelo con una straordinaria e coinvolgente nitidezza lenticolare; come già l’accattivante intuizione del capitolo iniziale, la simmetria cioè fra il silenzio scelto dal Manzoni e quello, ugualmente seppur tanto diversamente nevrotico, di Rossini, lasciava presagire. Non smentita, fino a chiusura di libro.