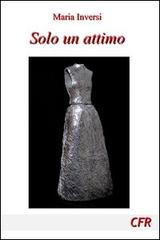
L’origine e la parola. “Solo un attimo” di Maria Inversi
Discorso intorno alla poesia a partire da “Solo un attimo” (Cfr, 2012) di Maria Inversi.
All’origine della parola poetica, nel tempo antico dei progenitori del mondo contemporaneo, viveva l’esperienza intima e pubblica del teatro.
Gli antichi metri delle composizioni in versi corrispondevano a tipologie teatrali, a intenti e parti strutturali dei drammaturghi creando, di fatto, una fusione tra le due realtà versificate vera e viva sin dal IV secolo.
In quei tempi terribili e vivi per l’intelletto che ancora ci regge, l’esperienza collettiva era il centro della produzione artistica, e questo impianto fortemente etico della scrittura, come della statuaria o dell’architettura, per citare solo alcuni aspetti dalla evidenza lampante, poteva esistere come elemento della vita antica di totale centralità e rilevanza poiché di fatto coincidente o complementare con il pensiero filosofico che scopriva il bisogno della fondabilità di un diritto condiviso, in cui coincidessero le molte aspettative e necessità di una comunità intera ed eterogenea, ma che, coesa nel nome della ricerca di un bene comune riconoscibile, incideva il proprio profilo scrivendo di fatto anche il nostro.
La poesia, nel lungo volgere di anni che hanno più o meno allontanato l’Occidente da questa sua radice portante, ha trovato una propria fisionomia, indipendenza quasi, da quel mondo in cui i componimenti, nel loro intento comunitario, erano stati persino, a lungo, anonimi.
Figlia di un intimismo assoluto, la poesia ha finito in gran misura, col direzionarsi sempre più verso ciò che erano state lirica e melica, delineando lo spazio dell’universo personale, intraindividuale, addirittura psicologico: e di questa anima, tutta intima, ha vissuto a lungo e ancora vive, specie dopo i picchi emersivi altissimi del lirismo baudelairiano e rilkiano. Luogo del sentimento -ma, vorrei aggiungere, mai della mera emozione- la poesia ha guadagnato l’ultima frontiera dell’individualismo nel tempo del ripiegamento personale: spazio ultimo, se non unico, di vita nel tempo della società di massa prima e della post modernità poi.
Questa condizione, di docile strumento del personale, ha spesso determinato il fraintendimento della sua stessa natura che è invece quella, dominante e potente, di riscossa capace del sentimento collettivo, di linguaggio ultraindividuale dalla capacità puntualizzatrice di individuazione nel singolo del proprio destinatario.
Ovviamente, tuttavia, fornendo della doverosa attenzione la lettura delle grandi opere di questi immensi maestri del pensiero lirico, ci si accorge facilmente di come nelle pieghe della loro struggente scrittura, si trovi, nella descrizione di un’epoca come dell’urgenza che questa medesima potesse conciliarsi con il frantumarsi dell’unità psichica del singolo, l’emersione della più profonda natura dell’arte sapiente del verso.
Poesia era ed è, oltre le spoglie del solipsismo emozionale, una vera passione civile, cioè di cives, etimologicamente cittadini della città stato, ma, in figura, immagine degli uomini racchiusi nella condizione di coesistenti, di rousseauniani animali sociali che non potrebbero neppure immaginarsi al di fuori di questo vincolo di appartenenza ed individualità singolare ma collettiva ad un tempo, imprescindibile.
Da qualche decennio, la passione poetica è ravvivata da una chiamata sempre meno diaristica in nome di una meditazione condivisibile della esperienza individuale che fortunatamente sopravvive avendo dimostrato e mantenuto il proprio valore cardinale del pensiero e del modo poetico.
L’individuo, sempre più esaltato nella sua realtà personale, esprime con forza la propria voce assoluta come un mistero incalcolabilmente e profondamente distinto e pur sempre appartenente alla realtà circostante; ed il suo sentimento della realtà diviene una sonda di conoscenza ultraintellettiva, metacognitiva del silenzio in cui il mondo, come un vuoto pneumatico, vede lanciata la sonda vivificante del mistero universale, rappresentata dal limite umano.
Questa esigenza doppiamente duplice, di osservazione e definizione da una parte; e dell’individuo e della comunità ultima cui appartiene dall’altra- una sorta di archetipa identità umana- esplode nell’esperienza poetica di Maria Inversi.
Esperienza poetica matura, poiché appare, significativamente, dopo una lunghissima ed acclarata attività drammaturgica, la scrittura di Maria, beneficia delle molte fonti appena accennate anche per i lunghi soggiorni di vita e di mestiere artistico spesi nelle città di Vienna e Parigi, cioè in quelle capitale della grande poesia moderna in cui forte era l’aura sonora ed estetica, oltre che lirica appunto del genio di Baudleaire e di Rilke. Giacché corradicale della lunga riflessione teatrale, la sua scrittura in versi, rispetta una chiara struttura di respiro, che facilita – insieme alle molte auerbachiane figure– il canto e la memoria, cioè la piena assimilabilità e trasmissibilità, fondendosi in ciò con l’altra e non diversa vena della sensibilità dell’autrice: quella del pensiero e del modo femminile, cui da sempre, nella società della scrittura, é demandato il compito sociale della tradizione orale, cioè della trasmissione dei valori attraverso la facoltà della parola.
Il mondo femminile, ampiamente esplorato e più volte agito sulla scena dalla Inversi, si piega qui all’intenzione di una oralità quasi oracolare, che spiega l’intenzione della scrittura come una riproposizione di pause, a più tratti enfatiche, ben espresse dalla estrema frammentazione del verso, anche in onore alla maniera ungarettiana post-parigina nella quale si assommavano, nelle intenzioni del Livornese, e quindi nella pratica odierna, lo studio di metri classici di altre culture (su tutte quella araba e quella giapponese) grazie alle quali fondere, nella grazia essenziale di immagini, l’assoluta profondità del vissuto umano.
Il valore olofrastico della versificazione acutamente settata di Maria Inversi, sposa la forza evocatrice dei poeti francesi anche, e soprattutto, attraverso il richiamo ad ambientazioni urbane mai artefatte, in cui la bellezza della città sembra prendere forma dall’imperfezione dei vicoli, dei dettagli sconnessi sempre correlativo oggettivo di una implicita denuncia d’amore, senza arginare mai quel senso di solitudine assoluta che però vi aleggia (penso alla sessione Adagio di Solo un Attimo non meno che ad alcuni inediti presentati per la lettura in memoria di Filippo Bettini il 4 luglio di quest’anno all’Auditorium di Mecenate) e che sembra scomparire assolutamente nel regno vivo di una natura panica, pacificata. Se pensiamo la splendida Adornerò con ciuffi di stelle nella sezione Adagio troviamo esplicitata, nell’estetica assoluta di un universo organizzato a guisa di cornice dell’individuo cioè sempre antropocentrico, la dichiarazione di una matrice profondamente classica, in cui il valore della bellezza e dell’armonia che per suo mezzo l’uomo riesce ad intercettare, in un afflato lirico e panico totalizzante, sposa il desiderio amicale, cioè di interruzione della solitudine : necessità cui l’intellettuale prima che la donna resta ancorata saldamente, come a cercare la stretta correlazione tra natura dell’esistenza e sua dimensione non eludendo lo stretto bisogno della mediazione intellettuale suprema: cioè quella dell’arte, ma attraverso questo medesimo linguaggio sempre e comunque in ciò rielaborato, conosciuta, dichiarata e affrontata.
La scrittura dunque, come il teatro, è luogo in cui viene fatta mostra del sentimento del reale. Luogo e palcoscenico di riflessione massima, che accede, dal luogo recondito delle molte esperienze dell’individuo, alla fonte di domande comuni, nella fattezza della loro comunicazione. La verità assoluta quindi, emerge qui, come nelle migliori opere, in una partitura aperta, accennata nel nome delle quattro sessioni in cui è strutturata la silloge (Arde il cielo; Adagio; Mani tese; Amica) e dai folti e fitti riferimenti musicali: tra tutti quello sempre vivo ai movimenti, oltre e prima che agli strumenti ed al genio evocato di Mozart prima e dell’amato Mahler poi: alla cui figlia è significativamente indirizzato il componimento citato, Adornerò di stelle. L’intenzione chiaramente sinestetica e sintetica dei folti richiami, sembra inseguire la rotta di un’ arte totale finalmente risolta nella verità dell’azione simultanea, onnipercettiva: le poesie, strutturate sempre come monologhi, richiamano la messa in scena degli adattamenti di carteggi di grandi donne del nostro tempo, centrali per caratura e spessore – novelle eroine del coraggio dell’identità, più che della diversità- che la stessa Autrice ha lungamente portato in scena. Eroine del sentimento umano, quelle figure amate diventano il segno inciso nel proprio essere donna eroicamente fedele e costante, intellettuale indefessa e totalmente votata alla causa della domanda archetipa, universale: su quale sia, appunto, questa natura indomita e diversa che spinge ed innamora, piegandola, persino l’umanità dominante.
Questo sentimento delle identità comuni, cioè anche delle differenze insopprimibili, spiega l’urgenza necessaria della ricerca di Maria Inversi, la quale, riutilizzando i molti archetipi e le forze endogene che ha sorbito con sensibilità rara nei molti luoghi e sentori della sua vita (dai campi sterrati attorno a Torino, alla disperata Roma notturna; alle già ricordate Parigi Bohemienne e all’Austria degli amati Mahler e Rilke), riaccende, in un estetismo perfettamente veicolato alla bellezza di certe atmosfere insuperate da Belle Epoque, un sentimento antichissimo e universale, che chiede a ciascuno ragione della propria differenza solo nella risposta fornita ai grandi, universali, interrogativi dell’arte.
Questo, probabilmente, è il senso del pieno disvelarsi della sessione centrale Adagio, in cui vero protagonista resta il valore comune della riflessione umana: della storia, attraverso il richiamo ininterrotto alle vestigia della Roma antica; e poi del mito e del Teatro, di Medea mi sento di poter dire (il richiamo al manto, alla bellezza disperata in Cadono stelle, dedicata ad Irene Papas); fino al pieno richiamo a Mahler, cui l’intera sessione sottende con riferimento implicito, specie al suo “Il canto della terra”. Il grande Maestro, autore della cosiddetta Sinfonia Assoluta, che nello sfaldamento dei tempi canonici delle parti sinfoniche sollecita il nostro intelletto emozionale ad una via transrazionale della cognizione della condizione umana, viene qui omaggiato, e fatto centro esatto, di un desiderio di superamento del linguaggio singolo di arte verso l’inseguimento di un core concorde di fronte al mistero ultimo che è il dolore, l’assurdo, la perdita.
Questi molti aspetti, fusi nel valore ctonio dell’universo femminile per più aspetti centrale nel componimento, si dispiegano in un omaggio perfettamente personale che puntualizza l’intenzione collettiva agita già da Inversi nel 2011 nella silloge ad otto mani “Il canto della terra”, in cui le artiste, con linguaggi e sensibilità diverse avevano dialogato con l’ultima Opera del gigante austriaco tentando di spiegare il mistero ultimo della Totalità: origine e fine di ogni cosa, come la terra Madre; archetipo di tutte le forze, vero motore dell’oltre razionale bià, questa scrittura di donne per le donne, ultimo destinatario dello sforzo mahleriano, si apre alla riflessione nuova ed originaria di Inversi che, attraversando il mondo perfettamente intatto del dovere della bellezza, cioè dell’immobilità verso cui le donne sono ancestralmente sospinte nel tentativo imposto verso del contenimento verso la via maestra della valorizzazione della sola ragione, spiega l’entropia prepotente dell’esistenza come uno scacco furtivo che il prepotere della vita si concede in termini di variabile vivifica alternativa e innescante: grazie alla quale le arcane forze dell’universo riescono sempre, nuovamente, a sovrastare il peso di un destino già segnato in forza di urgenze più strette, non secondarie, anche se non culturalmente dominanti.
Il pieno superamento di Adagio, nel senso di divulgativa prova del dato di realtà, resta lo sviluppo veloce di Mani tese, dove il tema dell’universale femminile si dispiega in una medesima estetica indirizzata però alla contingenza, e che, nei richiami (ancora una volta) germanofoni ai biondi capelli – detti carsici– (come non pensare alla disperata sorella di Trakl?) di Come fieno insegue il difficile compito di collezionare la risposta tanto individuale quanto spesso inconsapevole ad una vita spontaneamente e misteriosamente erotta oltre il (nostro) dolore di specie.
In ultima analisi, da questo prezioso libretto, emerge la rimodulazione d’un intero universo interpretativo e cognitivo, la cui interrogazione traspare condotta con doverosa e meticolosa serietà nei suoi molti linguaggi e nelle sue proteiformi affermazioni di poetica ora rifuse nel modo personalissimo di estrema fedeltà ad una vita di ricerca artistica avanzata in curiosità e rigore .
Maria pone qui i molti linguaggi dell’arte, la musica, il teatro, la letteratura e, in una certa qual misura anche la filosofia, in un cortocircuito intellettuale estremamente percorribile e fruibile nella duplice ed innovativa linea del binario culturale: l’una traccia, quella formale, caratterizzata dalla transcodificazione dei linguaggi d’arte in un fluido onnipervasivo dell’espressione dalle emersioni sensibili proteiformi; l’altra, quella del contenuto artistico, nella fissione dei grandi interrogativi dell’uomo moderno, pre e post contemporaneo: in un neoumanesimo concentrico, le domande mai formulate si fissano altissime e mute intorno alla dimensione esistenziale sua propria non meno che dell’alterità sempre sottesa nei versi che, ripeto, si aprono ed insistono in forma di dialogo, privilegiando la ricerca di una alterità speculare nella propria differenza e complementarietà.
Davvero il mondo che da questa bella prima silloge appare trasparire, è un mondo scomposto tra singoli oltre che tra generi. E’ un mondo che, nella frattura di questa scomposizione, sente stringere il peso di una solitudine esistenziale, universale; ma che riconosce nell’ algia della bellezza austera di ciò che è irraggiungibile e quasi miticamente predestinato ad una perfezione inappartenente, una sorta di pirandelliano “cielo di carta”: un contesto fittizio, se non una vera e propria finzione, nella quale battersi per la dignità dovuta ad una umanità patente e pulsante nella propria realtà specifica e specificamente diversa.
In ultima analisi, è questa frattura la matrice da cui nasce la solitudine del suo Io lirico, ultimo grande carattere tragico del teatro che da tutta la vita indaga ed onora. Da questa frattura si evolve il gesto importante della diversità rivendicata dell’universo femminile: ctonio e imperfetto, della morte come della vita, estremo ed estremamente avvertito, per il quale da sempre, con grande coraggio, chiede “asilo poetico” di inassimilabilità, di alterazione, universalmente umana, dei modelli: il diritto, finalmente, alla soggettività della risposta, di contro all’universale domanda dell’arte.
