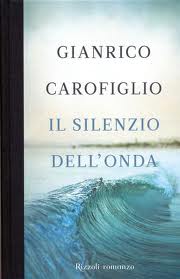
“Il silenzio dell’onda” e dell’onestà della Letteratura
Il “Silenzio dell’onda” è un romanzo onesto. Esiste l’onestà della letteratura? Sì, succede quando l’artificio non è gratuito, quando non si inganna il lettore.
Quando lo si coinvolge nella storia attraendolo pagina dopo pagina quel tanto che serve per condurlo oltre, all’essenza di un problema. Carofiglio fa così: usa stilemi da fiction poliziesca per dire altro.
Se possa darsi o meno un’onestà della letteratura è una questione affrontata in modo chiaro da Umberto Saba nel 1911, nel saggio dal titolo “Quel che resta da fare ai poeti”.
In momenti di crisi, quando le parole sembrano vuote e asservite a stereotipi magniloquenti, a chi scrive non rimane altro che praticare una costante e rara cura delle parole per esprimere con esattezza la propria visione, senza enfasi, senza false apparenze. Un richiamo quello di Saba alla responsabilità di una scrittura che rifugga da “intenzioni bottegaie o ambiziose”: perché pubblicare un libro non è come “urgere una decorazione” di sé, ma deve essere il frutto di uno scandaglio, di una ricerca di verità scevra da ogni compiacimento di maniera, per mantenersi onesti di fronte a se stessi e ai lettori. E dunque, dice Saba, contrapponendo alla magniloquenza sforzata di D’Annunzio la mediocrità sobria degli Inni sacri manzoniani ,“il poeta deve tendere ad un tipo morale il più remoto possibile da quello del letterato di professione, ed avvicinarsi invece a quello dei grandi ricercatori di verità esteriori o interiori”.
E Manzoni è un poeta “onesto” proprio perché “per non travisare il proprio io e non ingannare con false apparenze quello del lettore, resta se mai al di qua dell’ispirazione”; perché “egli credeva che Dio, che gli aveva dato il genio, gli avrebbe chiesto conto di ogni parola, direi quasi di ogni interpunzione”.
Il verso “mezognero”, continua Saba, può sembrare il migliore, essere il più acclamato: il romanzo “onesto” non vince il primo premio.
Manzoni non opera una manomissione/manipolazione delle parole, come direbbe Carofiglio, per un sentire religioso che diviene etica della scrittura. Mentre nel D’Annunzio che si esagera, si aumenta, si gonfia, c’è già il germe della tossicità della neolingua fascista. Siamo nel 1911, Saba intuisce l’aria di regime perché il suo richiamo all’onestà della letteratura è un’urgenza: quel che resta da fare quando tutto sembra perduto e forse è già perduto, perché questo articolo scritto per La Voce sarà censurato dalla rivista, ritenuto non pubblicabile.
Il pericolo è, come dirà Gramsci, nell’affermarsi di quel neolalismo settario che è la manifestazione patologica di un linguaggio tutto teso alla difesa di conventicole culturali e politiche. In cui parole come democrazia, libertà, uguaglianza perdono di valore.
Cento anni dopo in Italia, è ancor necessario salvare il linguaggio dalla crisi: “le nostre parole sono spesso prive di significato – scrive Carofiglio – ciò accade perché le abbiamo consumate, estenuate, svuotate con un uso eccessivo e inconsapevole. Le abbiamo rese bozzoli vuoti. Per raccontare dobbiamo rigenerare le nostre parole”. Dobbiamo “liberarle dai vincoli delle convenzioni verbali, dei non significati”. Perché, come dice Socrate a Critone , “il parlare scorretto non è solo cosa di per sé sconveniente, ma fa male anche alle anime”. E per questo è dunque necessaria “la cura, l’attenzione, la perizia da disciplinati artigiani della parola, non solo nell’esercizio attivo della lingua – quando parliamo quando scriviamo – ma ancor più in quello passivo: quando ascoltiamo, quando leggiamo” (G. Carofiglio La manomissione delle parole)
Carofiglio è un magistrato e uno scrittore: questo lo porta ad avere una doppia attenzione al linguaggio, sia etica che estetica. È estetica allora la parola che ha una valenza etica: come la Costituzione Italiana, testo di eccellenza linguistica e letteraria per chiarezza ed esattezza.
Carofiglio magistrato sa che nella stesura di un verbale, nel modo di porre domande in un interrogatorio o di considerare vera una testimonianza, sono le parole che fanno le cose, che creano la realtà: in un processo giudiziario la vita degli uomini dipende da una virgola.
È con questo spirito allora che Carofiglio scrittore riprende la tradizione del romanzo poliziesco italiano secondo la quale, da Gadda a Sciascia, ogni inchiesta su un delitto non può che prevedere un’interrogazione sulla conoscibilità del reale: il dubbio e lo scavo nelle parole che fanno i fatti sono il criterio migliore per arrivare a una possibile verità ultima.
Si crea così sul tavolo di lavoro di Carofiglio un continuum tra la riflessione su un uso legale del linguaggio e prassi narrativa: dai romanzi “Testimone inconsapevole” e “Ragionevoli dubbi” al saggio “La manomissione delle parole”; da “Il paradosso del poliziotto” a “Il silenzio dell’onda”.
E così i personaggi narrativi di Carofiglio si evolvono, partono da un’inchiesta sul reale per arrivare ad uno scandaglio profondo di sé: l’ultimo romanzo dello scrittore-magistrato segna proprio questo punto di arrivo. Il problema è come vedere le cose.
Già in “Testimone inconsapevole”, primo legal thriller della saga dell’avvocato Guido Guerrieri, il protagonista interrogava un’aula di tribunale sul rapporto tra vero e verosimile: la nostra percezione delle cose è così condizionata da stereotipi e automatismi del linguaggio, che il barista testimone è effettivamente convinto di aver visto il senegalese Abdou Thiam con il bambino bianco atrocemente assassinato. Anche se i fatti scagionano l’africano che non poteva essere lì, il barista è sicuro di ciò che dice perché in lui agisce inconsapevolmente la sua avversione razziale per gli ambulanti di colore. Il problema allora è andare oltre i filtri percettivi che condizionano la nostra visione del mondo: se due terzi di ciò che vediamo e dietro i nostri occhi, ossia nelle nostre convinzioni mentali, allora uno sforzo di onestà ci deve obbligare a disvelare il verosimile per arrivare il più possibile al vero. È uno sforzo che si deve al mondo, al senso di giustizia. Ma è uno sforzo che si deve in primis a se stessi. L’onestà delle parole sta nel non travisare il proprio io, dice Saba, che non a caso avrà molta esperienza di psicanalisi. Il tribunale più importante allora è quello davanti alla propria coscienza.
Gli antichi conoscevamo bene il legame tra linguaggio giudiziario e analisi di sé. Seneca nelle “Lettere a Lucilio”, nel “De ira” utilizza termini del registro giuridico per spiegare come sia necessario mettere sotto processo in noi i meccanismi che portano ai sentimenti negativi, alla rabbia, all’odio. È quello che oggi fa il paziente con un buon psicoterapeuta. È quello che fa con il suo dottore il carabiniere Roberto l’ultimo personaggio di Carofiglio: con “Il silenzio dell’onda” il magistrato-scrittore porta l’indagine dal piano della realtà al piano dell’interiorità psicologica.
Chiariamo subito che è un romanzo che scorre bene, con una “sceneggiatura” efficace, un montaggio da fiction con tanto di suspance che attira il lettore alternando riflessione e azione, l’onirico e il reale. È quello che in cinici termini editoriali si direbbe un buon prodotto: “Il silenzio dell’onda” si legge d’un fiato. Ma (ammesso che qui ci voglia un’avversativa, ammesso che profondità della scrittura e piacevolezza di lettura non siano cose serenamente conciliabili in un giudizio critico) , ma ciò che rende questo romanzo onesto, tornando ai parametri di Saba, è che non si esagera o addirittura si finge passioni che non siano del temperamento e dell’esperienza dello scrittore. Anzi, si ha l’impressione, come di fatto dimostra il percorso di Carofiglio qui delineato, che ogni parola venga da lontano, da lunga elaborazione; che ogni scena, ogni escamotage narrativo sia uno strumento per condurre il lettore ad altro, ad una riflessione sull’essere. “Il silenzio dell’onda” parla con onestà del dolore morale.
Roberto è un maresciallo dei carabinieri che ha fatto per anni l’infiltrato, fingendosi un trafficante di droga per poi incastrare i malviventi e metterli dentro. Roberto si è identificato talmente con la sua doppia vita da assumere su di sé rabbia, orrore, violenza, fino a che la malavita non è diventata per lui male di vivere, dolore di esistere. Si vive male a contatto con il crimine, nel crimine, ci si può ferire l’anima. Così Roberto è andato in frantumi e ora è in terapia dal “dottore” ed è una sofferenza e una lenta liberazione trovare le giuste parole per nominare il proprio inferno.
E poi c’è Emma, anche lei in cura, (intense e precise le pagine sui suoi naufragi affettivi), ma che diviene per Roberto l’inizio di una rinascita, in una relazione fatta di passeggiate notturne per Roma, di chiacchierate sul cinema e confessioni. E poi c’è Giacomo, un ragazzino di 12 anni di quelli che parlano poco e pensano e soprattutto sentono molto. Giacomo il suo male di vivere lo racconta al cane Scott che incontra nei suoi “sogni lucidi”, perché ciò che fai nel mondo reale dipende da ciò che fai da quella parte. Qui viene fuori un altro aspetto di Carofiglio: il praticante di arti marziali e di meditazione. È il “dottore”, accortamente mai definito nella sua specializzazione ma sicuramente più junghiano che freudiano, ad aiutare i suoi pazienti con la saggezza orientale.
E così Roberto impara a lasciare andare i pensieri negativi, scopre che camminare ponendo attenzione ai passi aiuta a liberare la mente, che i paradossi zen portano alla consapevolezza, che accettare la propria pazzia fa bene. E che vale la pena scommettere sull’esistenza di Dio, come diceva anche Pascal, per perdonarsi e darsi ancora una possibilità, riprendere a sperare.
In tutti i racconti di Carofiglio c’è un profondo Principio di Speranza, c’è la possibilità di scegliere di rigenerare se stessi e magari un po’ anche il mondo.
Qui la speranza è nell’immagine perfetta di quelle onde dell’Oceano, montagne d’acqua, che Roberto affrontava da bambino, con il padre: quando l’onda ti porta senti di fare parte e ti sembra che tutto finalmente abbia un significato.

