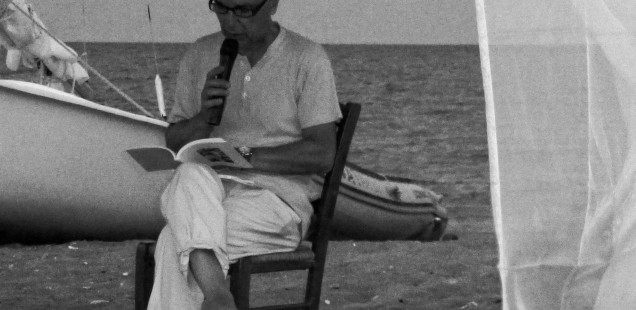
“C’è un cartello in alto sopra il sipario scarlatto”. Una poesia inedita di Giorgio Linguaglossa
“C’è un cartello in alto sopra il sipario scarlatto” è una poesia inedita del poeta e critico Giorgio Linguaglossa.
C’è un cartello in alto sopra il sipario scarlatto di Giorgio Linguaglossa
Inavvertitamente aprii la porta. […] e vidi
il palcoscenico del sonno.
C’è un cartello in alto sopra il sipario scarlatto.
V’è scritto a caratteri cubitali:
«Asilo privato dell’Ombra».
Un attore fa ingresso teatrale e un inchino
al pubblico:
«Siamo nell’asilo privato dell’ombra
o dei morti viventi
come lo chiamano i suoi detrattori
– spiega il saltimbanco –
dove gli umani dormono il loro geroglifico sonno
convinti di essere vivi e vegeti».
E qui c’è un battito di mani del pubblico.
«Di qua c’è il Ponte del Male, o del Bene, fate voi
– continua il buffone – di là
c’è Venezia che riposa sulla laguna
di Murano e di maioliche con i leoni alati
di San Marco, le grazie femminili del Tiepolo,
i palazzi del Doge…».
[…]
Nove sorellastre vestite di rosso siedono all’ingresso.
Un sentiero di ghiaia si biforca,
il primo conduce ad una torre di pietra grigia,
il secondo conduce ad una torre di pietra bianca,
ma è soltanto un abbaglio, entrambe le torri
sono la medesima torre,
i prigionieri dell’ombra vagano inconsapevoli
da una torre all’altra.
Siamo nella Torre della Felicità.
In alto, danzano sette rossi pagliacci.
In basso, un cancello astato avvolto dall’edera.
Oltre il cancello ci sono tre pianure
con delle belve di guardia agli ingressi.
[…]
«Ma dove?, quale cammino?», chiedo
ai prigionieri dell’ombra ma quelli non mi rispondono
e mi voltano le spalle.
«Un castello di carta che un soffio di vento insidia»,
mi dice un’ombra aldilà di un parapetto.
«Nessuna pioggia mai, c’è un sole splendente, notte e giorno.
Il sole nero della notte e il sole bianco del giorno.
I prigionieri bevono il sole nero della notte
e Marlene canta nel sole bianco del giorno».
Queste parole mi giunsero da un’altra ombra
che non potevo scorgere
tant’era fitta in quel luogo l’oscurità
ch’io persi l’orientamento.
[…]
In qualche modo, io e i prigionieri, arrivammo
al secondo cancello. L’aprimmo.
C’è un’altra pianura simile alla precedente.
Una tigre sferza con la coda il bitume dell’aria.
C’è un muro di calcestruzzo con sopra una ringhiera
di filo spinato attraversato dall’alta tensione
e degli specchi
che riflettono la luce del sole bianco
e accecano i prigionieri dell’ombra.
In uno specchio vedo come in un film uomini in fila indiana,
indossano un pigiama a strisce verticali,
d’un colore indistinto.
Guardie in divisa sulle torrette blindate
azionano dei riflettori. Gridano: «Achtung! Achtung!».
Camionette blindate recano in alto degli altoparlanti.
«Le epoche della felicità sono i suoi fogli vuoti!»,
gridavano quei miserabili.
Uomini in mimetica spingono i prigionieri
con il calcio dei fucili accanto a un filo spinato;
ci dicono di piegarci sulle ginocchia.
“No, non può essere questa la mia fine”, pensai
in quel momento.
E toccai la foto di Enceladon nella tasca interna della giacca.
Era ancora là.
Udii degli spari,
ma in sottofondo come in una nuvola di ovatta.
E scivolai in un sonno
pesante come cento lastre di piombo.
[…]
Terzo cancello.
Esito. Faccio un passo indietro.
Mi sporgo da una finestra: ancora
una pianura inesplicabile. La pianura del sonno.
Ci sono dei cavalli che dormono in piedi sotto la pioggia.
Fotogramma di città.
Sono nella folla che attende la metro.
“Gli umani (i copulatori del sonno)
sembrano vivi ma in realtà dormono,
un sonno simile alla mia morte”.
Mi venne in mente questo pensiero irragionevole,
non so perché.
“Il sonno della Ragione non genera più mostri
i mostri si alimentano da sé, gli uomini hanno sonno
ma il sonno genera la Ragione avvelenata”,
pensai questo pensiero
ma come un sopra pensiero di un altro pensiero…
Giorgio Linguaglossa è nato a Istanbul nel 1949 e vive e Roma. Nel 1992 pubblica Uccelli e nel 2000 Paradiso. Ha tradotto poeti inglesi, francesi e tedeschi. Nel 1993 fonda il quadrimestrale di letteratura «Poiesis» che dal 1997 dirigerà fino al 2005. Nel 1995 firma, il «Manifesto della Nuova Poesia Metafisica», pubblicato sul n. 7 di «Poiesis». È del 2002 Appunti Critici – La poesia italiana del tardo Novecento tra conformismi e nuove proposte. Nel 2005 pubblica il romanzo breve Ventiquattro tamponamenti prima di andare in ufficio. Nel 2006 pubblica la raccolta di poesia La Belligeranza del Tramonto.
Nel 2007 pubblica Il minimalismo, ovvero il tentato omicidio della poesia in «Atti del Convegno: È morto il Novecento? Rileggiamo un secolo», Passigli, Firenze. Nel 2005 esce il romanzo breve 24 Tamponamenti prima di andare in ufficio. Nel 2010 escono La Nuova Poesia Modernista Italiana (1980 – 2010) EdiLet, Roma, e il romanzo Ponzio Pilato Mimesis, Milano Nel 2011, sempre per le edizioni EdiLet di Roma pubblica il saggio Dalla lirica al discorso poetico. Storia della Poesia italiana 1945 – 2010. Nel 2013 escono il libro di poesia Blumenbilder (natura morta con fiori), Passigli, Firenze, e il saggio critico Dopo il Novecento. Monitoraggio della poesia italiana contemporanea (2000 – 2013), Società Editrice Fiorentina, Firenze. Ha fondato il blog lombradelleparole.wordpress.com
e-mail: glinguaglossa.@gmail.com

Un bel sogno poetico, questo di Giorgio Linguaglossa. L’impianto onirico nasconde una grande riflessione. La Ragione è sempre e comunque addormentata. Non vive mai in uno stato di veglia, come si vorrebbe far credere. Tranne il caso in cui abbassa la propria presunzione, ovvero la propria capacità di scegliere (tra il Bene ed il Male innanzitutto) e
le due torri, le due possibilità della scelta, si rivelano per quello che sono: un’illusione. Trovo semplicemente splendidi questi due versi: “Nessuna pioggia mai, c’è un sole splendente, notte e giorno. / Il sole nero della notte e il sole bianco del giorno”. Tutto è sempre e comunque splendente. Non so se Linguaglossa è d’accordo, ma a me sembra la descrizione dell’Eden. Mi congratulo vivamente.
Franco Campegiani
Trascrivo il Commento giunto alla mia e-mail della poetessa Anna Ventura
Commento alla poesia di Giorgio Linguaglossa “C’è un cartello in alto sopra il sipario scarlatto”.
Tento di analizzare questa poesia di Giorgio Linguaglossa, comparsa, in “Patria Letteratura”, che mi piace leggere con un mezzo critico artigianale: l’attenzione al numero: uno è il sipario scarlatto; uno è l’attore; una è la tigre; le torrette blindate ai lati del cancello che immette nel luogo del dolore sono due; i cancelli sono tre; sette sono i pagliacci rossi; nove le sorellastre vestite di rosso; cento le lastre di piombo. Se conoscessi la Cabala, forse potrei trovare una chiave di lettura originale; ma la mia esperienza non va oltre una banale lettura dei sogni. Forse mi potrebbe aiutare meglio lo studio dei Pitagorici, che feci nella notte dei tempi, ma che non ho dimenticato: questi grandi filosofi antichi sapevano leggere nei segni dei numeri molto più di quanto abbiano fatto, dopo, altri filosofi e altri uomini di scienza; loro sapevano che nulla, in natura, è occasionale, e che un preciso disegno comprende tutte le cose; l’intelligenza umana avrebbe, forse, spazi più ampi di quelli che le concediamo, ma noi siamo troppo presi dall’urgenza dell’immediato per trovare la via giusta per certe conoscenze: alle quali si arriva, talvolta, per strade forse più accessibili ad anime primitive: gli sciamani, i magari, le streghe, certe contadine. Nei testi di Giorgio Linguaglossa mi è sembrato di rinvenire, talvolta, questi misteriosi segni, e di cogliere l’ansia di volerli decrittare. Ansia, appunto: perché c’è, in questi testi, l’inquietudine di chi ha molto capito, ma vorrebbe andare oltre.
Un discorso parallelo si potrebbe fare anche a proposito del colore: rosso cremisi, o scarlatto è sempre il fondo dello scenario su cui compaiono i personaggi; verde è il bosco, l’albero, la foglia, i segni della positività e della crescita; bianco è lo sfondo del dolore, come una neve che arriva con la tormenta, e vorrebbe annientare ogni cosa: bianca, e innevata, è la strada che porta ad Auschwitz.
La cultura di Linguaglossa è troppo vasta per potere essere avvicinata con mezzi artigianali, e io mi rendo conto di questo azzardo; ma è questo il mio modo più autentico di avvicinarmi a qualunque discorso: fare tabula rasa di ogni conoscenza precedente, e affidarsi alle strade dell’intuizione e del cuore
ANNA VENTURA
Trascrivo lo scambio di e-mail tra Francesco Aronne e me:
Francesco Aronne «Veramente bella, oserei dire psichedelica e fortemente intrisa di divagazioni oniriche. E’ il tuo stile o meglio, quello che della tua produzione mi piace di più.»
Giorgio Linguaglossa: «Grazie Francesco, era una poesia che dormiva da più di 5 anni nel cassetto… poi un giorno si è svegliata e mi ha dettato il prosieguo… non so se c’è una chiave interpretativa, ciascun lettore è libero… »
Francesco Aronne: «Come ho avuto modo di dirti le mie letture non sono “tecniche” e sono diverse da quelle che fate voi “competenti del verso”.
Quando leggo, lo scritto o mi piace o non mi piace. Se mi piace, mi appassiona e lo divoro, altrimenti la lettura si impantana e non procede.
Non mi pongo tanti problemi e questa tua ultima decisamente mi piace. Se mi permetti la battuta, dovresti rovistare più spesso nei cassetti.
Naturalmente è solo una battuta, ma è curioso l’effetto del tempo nell’andare a riprendere alcuni versi, è come un cerchio che si chiude.
L’ho anche scritto nelle mie impressioni su “Blumenbilder”, riaffiorato da un oscuro profondo…
Un caro saluto.»
caro Francesco,
Caro Francesco Aronne,
io scrivo per le persone intelligenti non per i letterati, quindi questo tuo gradimento mi conforta, e anche parecchio, lo sai che sono alieno dalle lodi dei letterati (che quasi sempre sono insincere), invece questo tuo gradimento mi fa capire che forse sono sulla strada giusta.
un abbraccio. giorgio
Grazie Anna,
ho già postato il tuo commento su Patrialetteratura, come sempre sei andata dentro i meccanismi numerici che mi hanno guidato, non so nemmeno io che cosa significhino tutti quei numeri ma mi hanno aiutato a fare chiarezza 1, 3, 7, 9, 100… la poesia, come mi ha insegnato il mio maestro Osip Mandel’stam (di cui ho postato qualche giorno fa una poesia sul blog “Trovando il ferro di cavallo” del 1923) è una costruzione di scatole cinesi e di immagini una dentro e fuori l’altra, o che si attraversano a vicenda… alla fin fine, quello che ci rimane della vita è un susseguirsi di immagini… Nient’altro.
Una volta chiesi a mio padre, due giorni prima della sua morte, quale fosse il ricordo più bello della sua vita, e lui mi rispose quando da bambino camminava lungo la ringhiera sul lungomare di Ognina (Catania): di là c’era il mare azzurro. Fu allora che capii le immagini del mare azzurro che entrano nelle mie composizioni, e le ringhiere di filo spinato che si trovano qua e là, il parapetto di mattoni con al di là il mare… in un certo qual modo misterioso queste immagini si sono travasate da mio padre a me e sono approdate alla mia poesia… Senza che lui me le avesse mai rivelate… ma certe cose passano da padre in figlio in modo misterioso…
un caro saluto. Giorgio
Da una prima lettura è’ una poesia piena di DNA, di immagini oniriche, di uno splendido surrealismo. Trovoa per esempio fantastico questo passaggi:
“Un sentiero di ghiaia si biforca,
il primo conduce ad una torre di pietra grigia,
il secondo conduce ad una torre di pietra bianca,
ma è soltanto un abbaglio, entrambe le torri
sono la medesima torre,”
Ricorda tanti e nessuno. Questo secondo me me è il pregio massimo della tua scrittura. A volte quando qualcuno a commento non sa cosa dire, paragona l’autore di un brano a un altro ritenuto più illustre per fare un bel complimento.
Tu a me non ricordi altri che Giorgio Linguaglossa. Poi me la copio e incollo su un foglio di word perché mi darà piacere leggerla altre volte. Ciao
Trascrivo un commento di Alfredo De Palchi giunto alla mia email:
Caro Giorgio, da giorni un’influenza esagerata mi tiene al caldo a letto per evitare di essere colpito dalla polmonite fulminante, quella che si portò via in due giorni un amico l’anno scorso. A me non deve succedere tale fine, perché io anche la morte me la voglio guadagnare faticando.
Sono venuto al computer per restarci poco […] ho letto il tuo poemetto nel tuo post e
i commenti. Premetto che non sono mai stato un appassionato della poesia narrativa descrittiva decorativa etc., eccetto se. . . Sapessi spiegarti cosa contiene quel se. . . probabilmente sarei un critico.
Allora mi spiego nella seguente maniera. Il poemetto merita i complimenti, ma nessuno, a me sembra, menziona lo stile. È prosa in versi. Seguendo il mio criterio artistico (scusami per la mia certezza) il poemetto sarebbe una bellissima poesia in prosa se. . . con minimi ritocchi apparisse lineare, in blocco. Non capisco perché i poeti italiani evitano questa forma poetica che i francesi invece amano.
Ora vado a letto. Ciao.
Alfredo de Palchi
«Inavvertitamente aprii la porta […] e vidi / il palcoscenico del sonno». Così comincia “C’è un cartello in alto sopra il sipario scarlatto”, una composizione poematica di Giorgio Linguaglossa che si presenta smisurata e distratta ed è innanzitutto un lungo racconto onirico, un’irruzione di penna in territori non dominabili dalla forma construens, non a caso quelli da sempre praticati dalla mitopoiesi nelle sue infinite riproposizioni e varianze; territori e zone del mondo immaginato che la Modernità ha poi preteso di addomesticare per mezzo dell’analisi psicologica e delle sue discipline. Per mezzo: territori di mezzo sono quelli che la Modernità, prima dell’allontanamento delle scienze neuro-psichiatriche dalle impalcature magiche ed esorcistiche, prima di Freud e degli importanti viaggi anche a ritroso di Jung, ha cominciato ad indagare già con Edgar Allan Poe, l’esploratore delle zone tra veglia e sonno che sono all’origine del perturbante e ne sostanziano il nido. Poe è moderno perché all’incertezza e all’indeterminatezza, all’inadeguatezza cognitiva degli stati di coscienza intermedi attribuisce, appunto, oltre al connotato antico della fascinazione infinitamente trascinante, quello nuovo dell’indagabilità. In lui non agisce alcuna pretesa di guarigione dall’inquietudine, ma già l’ardire dell’intenzione addomesticante si spinge a visitare l’inesplorato con i nuovi strumenti dell’incremento percettivo e dell’isolamento decontestualizzante, che affina mirabilmente, con pertinacia ed entusiasmo. Poe si avvicina all’incubo come il domatore di leoni all’animale: non senza batticuore, ma nell’intenzione di ridurlo alla propria misura di intrattenitore. Freud, decenni dopo, intratterrà le sue pazienti isteriche nell’aspettativa, tutta tesa alla normalizzazione, dell’adattamento ad un’attesa sociale che chiamerà guarigione. Né guaritore, né intrattenitore, Linguaglossa sa la malattia essere condizione immedicabile della tarda stagione umana, segnata dal depotenziamento della forza propulsiva della ragione e dalla debolezza sentimentale; ed è nello stesso tempo alieno, nella sua pratica del verso, dalla filosofia poesca della composizione, mirata alla più evidente, alla più brillante delle riuscite formali. La sua poesia è infatti, come detto più su, smisurata e distratta: al limite, non è neanche poesia, se con questo termine intendiamo riferirci ad uno scritto caratterizzato dall’atteggiamento metaforico e dalla risonanza musicale, dall’uso misurato della frase e dalle ricorrenze metriche. Piuttosto, questo esemplare di scrittura si offre al lettore quale esercizio e saggio di una nuova letteratura senza attributi, pratica un tempo rara ed inusitata, che vede invece impegnati, oggi, non pochi tra i più avvertiti degli scriventi: e pratica, di nuovo, di mezzo. Né prosa, né verso, questo poema si trova a raccontare sbadatamente, in lessico come dimesso e vistosamente poco mediato da apparecchi e da figure retoriche, uno scenario multiplo e variato, che vede il soggetto proferente interagire con le moltitudini e con i paesaggi dopo essere stato introdotto da una sorta di presentatore, detto di volta in volta “attore, ”“buffone”, “saltimbanco”, in un curioso proscenio tripartito che potrebbe alludere a una dantesca commedia in trentaduesimo, o in sessantaquattresimo, se «Oltre il cancello ci sono tre pianure / con delle belve di guardia agli ingressi». Vi sono le muse, «Nove sorellastre vestite di rosso», vi sono i sentieri che si biforcano e le torri gemelle, una «di pietra grigia», una «di pietra bianca, / ma è soltanto un abbaglio, entrambe le torri / sono la medesima torre, / i prigionieri dell’ombra vagano inconsapevoli / da una torre all’altra. / Siamo nella Torre della Felicità. / In alto, danzano sette rossi pagliacci». Sono forse i peccati capitali? o magari le Pieridi ovidiane, gracchianti e decurtate di numero, messe lì a fare da contraltare alle Grazie e anch’esse abbigliate da clown in aderenza al fondale teatrale o circense del testo? Inoltrandoci nella lettura ci imbattiamo in scenari cupamente novecenteschi: «Marlene canta nel sole bianco del giorno», mentre «Uomini in mimetica spingono i prigionieri / con il calcio dei fucili accanto al filo spinato; / ci dicono di piegarci sulle ginocchia»: ma «”Il sonno della Ragione non genera più mostri / i mostri si alimentano da sé, gli uomini hanno sonno / ma il sonno genera la Ragione avvelenata”, pensai questo pensiero / ma come un sopra pensiero di un altro pensiero». E dunque lo sprofondamento del senso mitico ed allegorico porta al limite dell’insensatezza ecolalica: Linguaglossa fa il Poe all’incontrario, la sua scrittura smisurata e distratta appare del tutto adeguata ai tempi e agli scenari della contemporaneità.
Comprendo le riserve di Alfredo De Palchi, un poeta tra i più significativi dell’Italia dagli anni Cinquanta ad oggi. Caro Alfredo, tu ti sei formato stilisticamente al di fuori dei canoni e mini canoni che hanno imperversato nella poesia italiana nel secondo Novecento, inoltre la tua sensibilità, molto acuta, ti rende naturalmente scettico verso un tipo di poesia, come la mia, che si muove al di fuori della formula di lirica anti-lirica o post-sperimentalismo, poesia orfica o poesia del quotidiano o del minimalismo romano milanese. Se si raffronta il mio verso da “Blumenbilder” (1988) ad oggi, 21015, si scoprirà che ho abbandonato per sempre sia il pentagramma sonoro di “Blumenbilder” che l’endecasillabo tonico che utilizzavo in quegli anni lontani. Non so se questo sia meglio o peggio, ma c’era e c’è oggi bisogno in Italia di ampliare l’idea di forma-poesia (troppo chiusa e asfittica), di dare ad essa una «forma più capace» come scriveva Milosz nel 1953 in “Ars poetica”, che poi è stato il medesimo tentativo (purtroppo abortito) di “Lavorare stanca” (1936) di Cesare Pavese.
Si può anche provare a mettere il prosa la mia poesia, ne verrebbe fuori un’altra cosa, credo una cosa impoverita, perché nella mia scrittura del verso ho destrutturato qualsiasi pentagramma sonoro del Novecento per far oscillare le parole (o meglio le immagini) al di fuori del pentagramma, un po’ come teorizzato e praticato in musica da John Cage il quale teorizzò per la propria musica appunto questo: il lasciare che le note nuotassero fuori dal pentagramma. È chiaro che in questo orizzonte concettuale saltano tutti i parametri di riferimento con la poesia italiana precedente, e saltano per il semplice fatto che ho de-strutturato il pentagramma tonale della poesia italiana del secondo Novecento, non l’ho sostituito con un altro, diciamo, pentagramma, ma l’ho semplicemente abolito. Che poi se andassimo a vedere, molti miei versi sono costruiti con un andamento endecasillabico ipotonico (molto contiguo alla prosa). Fatto sta che alla lettura questo tipo di poesia produce (lo capisco benissimo) UN MOTO DI RIPULSA. Ma si tratta, anche qui di una percezione immediata, dovuta alla lontananza da quel pentagramma che dal Montale di “Satura” (1971) in poi ha imperversato nella poesia italiana. Dunque, spostare Montale, e spostando Montale si sposta tutto il paesaggio della poesia italiana del secondo Novecento, cambia il paesaggio e il panorama, e cambiano anche i nostri occhi e il nostro sguardo.
La mia poesia ha un fortissimo debito di riconoscenza con quella di Mandel’stam, di Milosz, di Herbert, di Transtromer piuttosto che con la poesia italiana del Novecento. Sono, insomma, un po’ come un esule in patria. Ma questa scelta è stata necessitata, non potevo fare diversamente.
Trascrivo un comento della poetessa Laura Canciani giunta alla mia e-mail:
In quell’avverbio dell’inizio “inavvertitamente” c’è la profonda umanità della tua poesia, siamo subito gettati nel mondo, nell’atto di aprire una porta, un gesto che compiamo miliardi di volte nel corso della nostra vita, un atto domestico, semplicissimo, che dimentichiamo subito, eppure è qui che si rivela la grandezza di un poeta, in quell’attacco in minore, quasi casuale, sotto tono. È una spada tesa a ferire gli uomini che dormono. Penso che sei un poeta di grandissimo livello, ed è qui che nasce il problema, è difficile ammetterlo per chi scrive versi. E poi la magnifica simbologia del “Palcoscenico dell’Ombra”, tutta la poesia è una magnifica visione della condizione storica ed esistenziale dell’Occidente e del nostro paese.
“Il sonno della Ragione non genera più mostri
i mostri si alimentano da sé, gli uomini hanno sonno
ma il sonno genera la Ragione avvelenata”,
pensai questo pensiero
ma come un sopra pensiero di un altro pensiero…
Quando e se gli uomini usciranno dal sonno, scopriranno che un universo di bellezza inaudita è già dentro di loro se solo riuscissero a controllare l’avidità e la falsa coscienza, cause principali dei mali del mondo. La tua poesia sull’Ombra parla di noi molto da vicino.
Con ammirazione.
Laura Canciani
«Inavvertitamente aprii la porta […] e vidi / il palcoscenico del sonno». Così comincia “C’è un cartello in alto sopra il sipario scarlatto”, una composizione poematica di Giorgio Linguaglossa che si presenta smisurata e distratta ed è innanzitutto un lungo racconto onirico, un’irruzione di penna in territori non dominabili dalla forma construens, non a caso quelli da sempre praticati dalla mitopoiesi nelle sue infinite riproposizioni e varianze; territori e zone del mondo immaginato che la Modernità ha poi preteso di addomesticare per mezzo dell’analisi psicologica e delle sue discipline. Per mezzo: territori di mezzo sono quelli che la Modernità, prima dell’allontanamento delle scienze neuro-psichiatriche dalle impalcature magiche ed esorcistiche, prima di Freud e degli importanti viaggi anche a ritroso di Jung, ha cominciato ad indagare già con Edgar Allan Poe, l’esploratore delle zone tra veglia e sonno che sono all’origine del perturbante e ne sostanziano il nido. Poe è moderno perché all’incertezza e all’indeterminatezza, all’inadeguatezza cognitiva degli stati di coscienza intermedi attribuisce, appunto, oltre al connotato antico della fascinazione infinitamente trascinante, quello nuovo dell’indagabilità. In lui non agisce alcuna pretesa di guarigione dall’inquietudine, ma già l’ardire dell’intenzione addomesticante si spinge a visitare l’inesplorato con i nuovi strumenti dell’incremento percettivo e dell’isolamento decontestualizzante, che affina mirabilmente, con pertinacia ed entusiasmo. Poe si avvicina all’incubo come il domatore di leoni all’animale: non senza batticuore, ma nell’intenzione di ridurlo alla propria misura di intrattenitore. Freud, decenni dopo, intratterrà le sue pazienti isteriche nell’aspettativa, tutta tesa alla normalizzazione, dell’adattamento ad un’attesa sociale che chiamerà guarigione. Né guaritore, né intrattenitore, Linguaglossa sa la malattia essere condizione immedicabile della tarda stagione umana, segnata dal depotenziamento della forza propulsiva della ragione e dalla debolezza sentimentale; ed è nello stesso tempo alieno, nella sua pratica del verso, dalla filosofia poesca della composizione, mirata alla più evidente, alla più brillante delle riuscite formali. La sua poesia è infatti, come detto più su, smisurata e distratta: al limite, non è neanche poesia, se con questo termine intendiamo riferirci ad uno scritto caratterizzato dall’atteggiamento metaforico e dalla risonanza musicale, dall’uso misurato della frase e dalle ricorrenze metriche. Piuttosto, questo esemplare di scrittura si offre al lettore quale esercizio e saggio di una nuova letteratura senza attributi, pratica un tempo rara ed inusitata, che vede invece impegnati, oggi, non pochi tra i più avvertiti degli scriventi: e pratica, di nuovo, di mezzo. Né prosa, né verso, questo poema si trova a raccontare sbadatamente, in lessico come dimesso e vistosamente poco mediato da apparecchi e da figure retoriche, uno scenario multiplo e variato, che vede il soggetto proferente interagire con le moltitudini e con i paesaggi dopo essere stato introdotto da una sorta di presentatore, detto di volta in volta “attore, ”“buffone”, “saltimbanco”, in un curioso proscenio tripartito che potrebbe alludere a una dantesca commedia in trentaduesimo, o in sessantaquattresimo, se «Oltre il cancello ci sono tre pianure / con delle belve di guardia agli ingressi». Vi sono le muse, «Nove sorellastre vestite di rosso», vi sono i sentieri che si biforcano e le torri gemelle, una «di pietra grigia», una «di pietra bianca, / ma è soltanto un abbaglio, entrambe le torri / sono la medesima torre, / i prigionieri dell’ombra vagano inconsapevoli / da una torre all’altra. / Siamo nella Torre della Felicità. / In alto, danzano sette rossi pagliacci». Sono forse i peccati capitali? o magari le Pieridi ovidiane, gracchianti e decurtate di numero, messe lì a fare da contraltare alle Grazie e anch’esse abbigliate da clown in aderenza al fondale teatrale o circense del testo? Inoltrandoci nella lettura ci imbattiamo in scenari cupamente novecenteschi: «Marlene canta nel sole bianco del giorno», mentre «Uomini in mimetica spingono i prigionieri / con il calcio dei fucili accanto al filo spinato; / ci dicono di piegarci sulle ginocchia»: ma «”Il sonno della Ragione non genera più mostri / i mostri si alimentano da sé, gli uomini hanno sonno / ma il sonno genera la Ragione avvelenata”, pensai questo pensiero / ma come un sopra pensiero di un altro pensiero». E dunque lo sprofondamento del senso mitico ed allegorico porta al limite dell’insensatezza ecolalica: Linguaglossa fa il Poe all’incontrario, la sua scrittura smisurata e distratta appare del tutto adeguata ai tempi e agli scenari della contemporaneità.
Trascrivo un commento giunto alla mia e-mail da Andrej Silkin:
caro Giorgio,
tu hai scritto: «Ut pictura poesis. Noi sappiamo che nel discorso poetico del tardo Novecento sono venuti a cadere i grandi racconti della decadenza come anche i piccoli racconti dell’io solitario che accudisce la reificazione del discorso poetico ad uso dell’io. La «derealizzazione» che ha colpito gran parte della poesia contemporanea fa sì che i contenuti di verità siano tra di loro indistinguibili in quanto contigui alla esperienze del valore di scambio, alle esperienze virtuali, a quelle immaginarie, a quelle ad alto tasso di probabilità statistica e stocastica che hanno una altissima percentuale di accadimento e di inveramento. La «derealizzazione» del mondo attecchisce anche alla forma-poesia: tendono a scomparire i confini tra i generi e, all’interno del genere, la forma-poesia tende a perdere i connotati di riconoscibilità.»
Ebbene, la tua poesia è una conferma di quel fenomeno che tu stesso chiami «derealizzazione» del mondo e della forma-poesia. Un fenomeno ontologico. I salti tra passato e presente, gli stacchi di immagini, gli interni e gli esterni che si susseguono e si alternano, gli zoom della macchina da presa sono caratteristiche inevitabili della tua poesia, che si nutre della “prosa del mondo” come diceva Hegel, che non è più adatta al canto eufonico di altre epoche storiche e stilistiche. La poesia è un campionario di frammenti, di relitti, di detriti che tu hai saputo amalgamare per costruire un monumento all’Epoca del Sonno, l’epoca che viviamo come sotto l’influsso di una macchinazione, di una magia. Forse è l’unico modo per raccontare il nostro universo, la peristalsi, il disequilibrio, la spezzatura, le faglie, le rotture, le distassie, le disarmonie, le dismetrie sono tutti espedienti che tu utilizzi per costruire una poesia di amplissimo respiro, che sia duratura quanto il nostro mondo.
Linguaglossa entra in questa poesia dalla porta del sogno “inavvertitamente”, cioè quasi per caso, e la scena che l’io narrante vede e (de)scrive ha le caratteristiche di una eccezionalità del tutto surreale, con tratti visionari ed onirici che sfiorano l’assurdo e il grottesco; una eccezionalità che si fa fatica a contestualizzare per l’estremo straniamento dei “loci” poetici, dove i numeri sembrano voler dire e invece accennano, tutt’al più suggeriscono, dove arrivano ammicchi ed echi letterari ( da grandi opere – La Divina Commedia, innanzitutto-) assolutamente vaghi pur se allusivi. Così come la voce narrante (perché questa composizione è innanzitutto racconto poetico e quasi sogno sognato), anche il lettore ha difficoltà ad orientarsi in questa foresta di simboli un po’ baudelairiana, e allora si abbandona all’accattivante flusso diegetico, si lascia guidare dalla storia che si svolge sul palcoscenico di questo teatro, anche se le spiegazioni che qualche voce fornisce sono quasi sempre oscure e mal rispondono alle domande. Per di più gli omissis alimentano l’indeterminatezza e cospirano a potenziare l’effetto surreale. La sensazione finale, che emerge dal complesso dei piani rappresentativi attraverso richiami, rimandi e spie, è che il poeta abbia voluto dire di un viaggio, quello dell’uomo attuale che si è perso nella vita, anzi che non ha mai trovato la strada giusta, e brancola, talvolta dietro altrui interpretazioni e improbabili segnacoli. Un viaggio che, nell’apparente indifferenza narrativa, cela il dramma dell’uomo d’oggi. E della sua storia, che il poeta dice con il labbro piegato ad amara stupefazione.
Pasquale Balestriere
Trascrivo il commento di Pasquale Balestriere giunto alla mia e-mail:
Caro Giorgio, qui di seguito le mie impressioni sulla tua poesia..
Linguaglossa entra in questa poesia dalla porta del sogno “inavvertitamente”, quasi per caso, e la scena che l’io narrante vede e (de)scrive ha le caratteristiche di una eccezionalità del tutto surreale, con tratti visionari ed onirici che sfiorano l’assurdo e il grottesco; una eccezionalità che si fa fatica a contestualizzare per l’estremo straniamento dei “loci” poetici, dove i numeri sembrano voler dire e invece accennano, tutt’al più suggeriscono, dove arrivano ammicchi ed echi letterari ( da grandi opere – La Divina Commedia, innanzitutto-) assolutamente vaghi pur se allusivi. Così come la voce narrante (perché questa composizione è innanzitutto racconto poetico e quasi sogno sognato), anche il lettore ha difficoltà ad orientarsi e allora si abbandona all’accattivante flusso diegetico, si lascia guidare dalla storia che si svolge sul palcoscenico di questo teatro, anche se le spiegazioni che qualche voce fornisce sono quasi sempre oscure e mal rispondono alle domande. Per di più gli omissis alimentano l’indeterminatezza e cospirano a potenziare l’effetto surreale. La sensazione finale, che emerge dal complesso dei piani rappresentativi attraverso richiami, rimandi e spie, è che il poeta abbia voluto dire di un viaggio, quello dell’uomo attuale che si è perso nella vita, anzi che non ha mai trovato la strada giusta, e brancola, talvolta dietro altrui interpretazioni. Un viaggio che, nell’apparente indifferenza narrativa, cela il dramma dell’uomo d’oggi. E della sua storia che il poeta dice con il labbro piegato a stupefatto ed amaro sorriso.
Un caro saluto
Pasquale Balestriere
Trascrivo il commento di Aldo Onorati giunto alla mia e-mail:
Caro Giorgio,
Il tuo poemetto (non è un diminutivo di qualità) ha un incipit a scatola ‘chiusa’ e una chiusa aperta. L’atmosfera kafkiana, dantesca e shakespeariana fanno da benzina all’originalità del tuo dettato. “Asilo privato dell’ombra” e il Ponte del Male oppure del bene (fate voi: le realtà si identificano al vertice, ma si distanziano secondo il punto di vista): potente metafora dell’Assurdo che spiega i mali del mondo e capovolge il dettato leibniziano, ma trascina con sé i paradigmi hegeliani, scrollandoli. E’ una sorta di lucida allucinazione a fini gnomici, ma dall’assurdo esce la verità (o le verità), in quanto è facile dire le cose scontate (è il vizio fortunato degli scrittori italiani di oggi che hanno il grande coraggio di affermare -dopo 70 anni-, credendo di scoprire ‘America, che i fascisti avevano il manganello); ma è difficile, se non difficilissimo, far apparire la realtà scuotendo i lettori attraverso l’impossibile (che è l’unico “possibile”). E’ una poesia epica, dal ritmo narrativo fluente nell’ipermetro con riallacci di sapienti endecasillabi di preferenza “a maior” e di novenari, settenari, per cui la musicalità non è mai spezzata, mai interrotta (tutto è passato al vaglio anche d’una tecnica del verso sottile e peculiare). Il sole nero della notte e il sole bianco del giorno sono translitterazioni, così come è un programma filosofico vergato in ambito lirico il potente verso “Le epoche della felicità sono i suoi fogli vuoti!”; il perdere l’orientamento del poeta e le fiere mi fanno pensare all’introduzione della “Divina Commedia”, ma qui ci sono i prigionieri: e i cancelli! Nella chiusa che inizia nella folla che attende la metro, c’è il senso dell’apparente “non-senso” del poemetto: una sorta di dichiarazione aperta, una verità apocalittica: i mostri si alimentano da sé. Ai lettori spetta continuare con il soprappensiero e “l’altro pensiero” di questo magnifico frutto.
Aldo Onorati
Si cerca, qui, una verità irraggiungibile, quella di un uomo sperso nei suoi condizionamenti e nelle sue dismisure. La si cerca tramite una irrealtà visionaria, nascosta e volutamente mascherata da una tessitura allegorico-iperbolica che tende a fare della lingua un percorso antipoetico. Tutto è razionale, studiato, e complesso. Tutto è calcolato. Mentre il canto si ciba di semplicità emotivo-verbale. La vera poesia commuove, suscita brividi alla prima lettura; questa sicuramente no.
Tanta cultura, tanta capacità rielaborativa, tanta vis speculativa, e, se si vuole, immaginifica, di cui la poesia può fare anche a meno. Qui Giorgio si distacca dalla solita sua realtà grigia, dal suo minimalismo a volte convulso, dalla sua “astoricità” per farne “une rêverie” di complessa suggestione surreale. Ciò che di veramente poetico ci trovo è quella sinfonia architettonicamente ottenuta da un melange di misure metriche che completano la loro esplosione in endecasillabi di fluida romanza lirica. Cosa veramente nuova nella Poesia di Giorgio.
Nazario
Trascrivo un commento di Nazario Pardini giunto alla mia e-mail:
Si cerca, qui, una verità irraggiungibile, quella di un uomo sperso nei suoi condizionamenti e nelle sue dismisure. La si cerca tramite una irrealtà visionaria, nascosta e volutamente mascherata da una tessitura allegorico-iperbolica che tende a fare della lingua un percorso antipoetico. Tutto è razionale, studiato, e complesso. Tutto è calcolato. Mentre il canto si ciba di semplicità emotivo-verbale. La vera poesia commuove, suscita brividi alla prima lettura; questa sicuramente no.
Tanta cultura, tanta capacità rielaborativa, tanta vis speculativa, e, se si vuole, immaginifica, di cui la poesia può fare anche a meno. Qui Giorgio si distacca dalla solita sua realtà grigia, dal suo minimalismo a volte convulso, dalla sua “astoricità” per farne “une rêverie” di complessa suggestione surreale. Ciò che di veramente poetico ci trovo è quella sinfonia architettonicamente ottenuta da un melange di misure metriche che completano la loro esplosione in endecasillabi di fluida romanza lirica. Cosa veramente nuova nella Poesia di Giorgio.
Nazario Pardini
Trascrivo un commento del poeta Ubaldo Derobertis giunto alla mia email:
Nell’attimo, scorgendo: sipario teatro e per il fatto che è menzionato il pubblico, ho pensato che potevo intendere meglio la tua composizione: C’è un cartello in alto sopra il sipario scarlatto, trovando il modo di leggerla, di recitarla. Poi mi sono accorto che non era un vantaggio a causa del limite ritmico, la scarsa qualità tonale, e per il fatto che essa non presenta accenti di intensità. L’occhio, preso dal virgolettato, ha badato allora agli intervalli creati dai dialoghi, ma anche questi svaniscono dietro la sequenza dei fotogrammi visti come in un film, al cospetto dei potenti significati. Alla fine ho avuto la sensazione che tu abbia trattenuto troppo l’emozione nel rievocare queste lacerate/macerate immagini. Mi è sembrato un lavoro novità pur difficilissimo, ma pur sempre di un lavoro si tratta, di un distacco troppo “crudele”. Immagini che, dal canto di Marlene Dietrich, ci conducono alle camionette naziste, alla strada che porta al campo di concentramento di Auschwitz, al filo spinato poi, se ho ben inteso, il richiamo a Encelado mi ha condotto in Sicilia, a Catania, al paese Linguaglossa, a Santo Calì che ci è vissuto, etc. qualcosa di autobiografico in senso stretto. Certo, devo ammettere che, pur con i rilievi sovra esposti, le difficoltà, le limitazioni ravvisate, questa poesia una volta letta continua a parlarmi! La difficile cadenza dei versi ti fa ugualmente entrare negli ambienti spirituali e fisici evocati in senso surreale, metafisico: i sentieri che si biforcano di Borges, gli abbagli: entrambe le torri sono la medesima torre, e Goya con ll sueño de la razón produce monstruos.
Lapidario il pensiero conclusivo: i mostri si alimentano da sé, gli uomini hanno sonno ma il sonno genera la Ragione avvelenata.
Caro Giorgio, pur trovandoci in un sogno, immersi nel sonno profondo, mi sarei aspettato qualcosa di più “sfrenato”, immediato. Ho tuttavia ben accolto l’eleganza dello stile, il nitore, la schiettezza, l’equilibrio tra immagine e pensiero.
Ma io sono, senza alcuna possibilità di cedimento, un estimatore delle tue in Blumenbilder.
Cari saluti, Ubaldo Derobertis
Verissimo, caro Ubaldo, quello che tu scrivi è vero, i versi del testo sono assemblati non per le loro qualità tonali quanto per la strumentazione articolatoria che rifugge la sonorità di altra mia poesia tipo “Blumenbilder” (la cui stesura risale a 26 anni fa), quella sonorità che ho abbandonato perché nel frattempo è cambiato il mondo e sono cambiato anch’io (e anche la poesia, credo), insomma, si tratta di un cammino che ho percorso e in questo cammino molto è stato abbandonato e forse qualcosa è stato acquistato, ma ho dovuto percorrerlo per non apparire un poeta arretrato attestato su un canto sonoro che stava dentro un pentagramma ben preciso, insomma, sono uscito dal pentagramma per approdare nello spazio interstellare dove non ci sono più orbite sicure. In questo tragitto di ricerca ci ho messo 30anni, ed è stato estenuante. Quello che volevo far giungere al lettore era proprio quello che tu hai descritto: di evitare la facile catarsi, di rendere non agevole né godibile alla lettura a voce la poesia ma, in qualche modo, renderla non facilmente dimenticabile.
un caro saluto Giorgio
Trascrivo il commento del poeta Umberto Simone giunto alla mia email:
Questa poesia è piena di sorprese. Tocchi da byline russa (le sorellastre, le torri, il sole e la luna ) e magici sfondi (le pianure dietro i cancelli con belve di guardia) alla Chrétien de Troyes, o alla Delvaux. Aggettivazione, dal geroglifico sonno all’astato cancello, parca ma estremamente raffinata. Una foschia grigionera che a tratti si infittisce a tratti si colora di bagliori rossastri, ombre sui parapetti, tigri dalla coda sferzante, finestre cha appaiono dal nulla … mi piace, mi piace! E per quanto riguarda gli accostamenti alla prosa, francamente proprio non li capisco: nella prosa non ci sono gli accapo, e qui ogni accapo è esattamente al posto suo, perché ogni volta sottolinea una parola oppure un particolare, o per un attimo almeno evoca un ritmo appena accennato e continuamente cangiante. Caro Giorgio, io non sono capace di dotte esegesi, ma ti faccio i miei più sinceri complimenti.
Umberto Simone
Trascrivo il commento del poeta Michele Arcangelo Firinu giunto alla mia email:
C’è un cartello in alto sopra il sipario scarlatto di Giorgio Linguaglossa
La poesia di Giorgio Linguaglossa “C’è un cartello in alto sopra il sipario scarlatto” mi ha intrigato tanto da tenermi compagnia per diversi giorni.
Si tratta di una poesia complessa e molto originale, fuori dagli alvei novecenteschi e tutta giocata sulle immagini. Per entrarci richiede diverse riletture ed attraversamenti.
Ma vediamo attraverso quali procedure stilistiche si realizzano queste rappresentazioni.
La poesia procede attraverso il racconto di un narratore che guida noi lettori-spettatori a immergerci nelle sequenze del sogno. Quadrupla trasformazione nostra fuori scena: da lettori a spettatori teatrali, a spettatori di un film a sognatori protagonisti sulla scena delle vicende osservate; quando “c’è un battito di mani del pubblico” (v. 14) quel pubblico non siamo già più noi, noi eravamo già stati immessi dentro la scena, dal v. 8,
“nell’asilo privato dell’ombra
o dei morti viventi”,
dove gli umani dormono il loro geroglifico sonno
convinti di essere vivi e vegeti”.
Il narratore esordisce (voce fuori campo) in prima persona, inizialmente al passato remoto “aprii”, “vidi” passa subito al presente e procede narrando o, per meglio dire, descrivendo, semplicemente evocando: “qui c’è; in alto c’è; qua; là; siamo; un sentiero si biforca; in basso…” .
La fascinazione è data dalle scenografie sospese, da sogno, dalle immagini che invitano a letture allegoriche soggettive, che suggeriscono, alludono più che disegnare in maniera completa, nonché dalla precarietà delle atmosfere continuamente cangianti e delle azioni sfuggenti. L’unità di luogo e d’azione è continuamente contraddetta e turbata dalle mutazioni sceniche.
Insieme alle trasformazioni sceniche evolvono i mezzi espressivi, i linguaggi. Si apre una porta e siamo in un palcoscenico e contemporaneamente in un sogno. Il teatro si slarga e cangia senza soluzioni di continuità in lagune, si scivola dal palco a Murano, da Piazza San Marco a Venezia a un museo con gli oli di Tiepolo, a ponti, torri, cancellate, campi di concentramento, atmosfere da café-chantant, fucilazioni. Noi siamo al contempo lettori, spettatori e attori del dramma, siamo i morti viventi, i fucilati di Auschwitz. Siamo in una poesia che a ben vedere usa tutti i mezzi espressivi del linguaggio cinematografico mediante un montaggio rapido condotto con sequenze, stacchi, campi, repentini cambi di scene, rovesciamento di interni in esterni, dissolvenze, dissolvenze incrociate (come del caso delle due torri che diventano un’unica torre).
Inutile ripetere quanto notato giustamente da altri. Eugenio Lucrezi vede “il soggetto proferente interagire con le moltitudini e con i paesaggi dopo essere stato introdotto da una sorta di presentatore, detto di volta in volta “attore, ”“buffone”, “saltimbanco”, in un curioso proscenio tripartito che potrebbe alludere a una dantesca commedia in trentaduesimo, o in sessantaquattresimo, se «Oltre il cancello ci sono tre pianure / con delle belve di guardia agli ingressi». “Lucrezi legge con esattezza nelle «Nove sorellastre vestite di rosso» le Muse e ipotizza che i “sette rossi pagliacci” rappresentino i sette peccati capitali.
Anna Ventura pone attenzione al numero, che svela una propensione dell’autore al cabalistico o alle teorie dei Pitagorici.
Ancora Lucrezi osserva gli “scenari cupamente novecenteschi: «Marlene canta nel sole bianco del giorno», mentre «Uomini in mimetica spingono i prigionieri / con il calcio dei fucili accanto al filo spinato; / ci dicono di piegarci sulle ginocchia»”. Così come Laura Canciani, che apprezza “la “magnifica simbologia del “Palcoscenico dell’Ombra”, e giudica tutta la poesia come “una magnifica visione della condizione storica ed esistenziale dell’Occidente e del nostro paese.”
Veniamo al linguaggio, che è piano, prosastico, antilirico ed esclude la musica dalle parole. “(…) ho de-strutturato il pentagramma tonale della poesia italiana del secondo Novecento, non l’ho sostituito con un altro, diciamo, pentagramma, ma l’ho semplicemente abolito” dichiara l’autore.
Al poeta Alfredo De Palchi la poesia è apparsa “prosa in versi”, al punto dal voler suggerire di trascriverla “lineare, in blocco”, per darle la forma che le competerebbe di “poesia in prosa”. Mi è capitato per caso di verificare tale ipotesi. Volevo fare un copia-incolla della poesia per trasferirla dal Web a una pagina Word, ma una bizza elettronica me l’ha copiata senza rispettare le cesure dei versi stabilite dall’autore. La poesia non era più la stessa, non funzionava allo stesso modo. Ne ho parlato con Linguaglossa e dopo la nostra telefonata ho voluto completare la verifica, così l’ho messa lineare, in blocco ma il risultato è stato di toglierle di dosso lo spirito poetico che aveva nella versificazione originale. Ho preferito rileggerla nella forma originale versificata. A questo punto penso che Linguaglossa abbia rinunciato, sì alla tonalità del pentagramma, ma che non abbia tolto del tutto il pentagramma, mantenendo il ritmo.
Veniamo alla conclusione di questa commedia buffonesca e sferzante, in cui non vanno persi i richiami allusivi alla Divina Commedia, trasformata qui in farsa tragica, amarissima. Senza speranza. Il rischio sembrerebbe questo, in uno smarrimento nichilistico di un “pensiero irragionevole”:
“Il sonno della Ragione non genera più mostri
i mostri si alimentano da sé, gli uomini hanno sonno
ma il sonno genera la Ragione avvelenata”,
pensai questo pensiero
ma come un sopra pensiero di un altro pensiero…
Roma, 25 gennaio 2015 Michele Arcangelo Firinu
Onirismo e surrealismo a parte, mi compiaccio che anche tu frequenti l’allegoria.
Lelio
Trascrivo un commento giunto alla mia e-mail da una persona che vuole rimanere anonima:
Gentile Linguaglossa, avevo sentito parlare di lei con parole spregiative e di ostilità, così, per gioco, non conoscendola, ho provato a girovagare un po’ per il web alla ricerca di sue poesie per potermi fare una idea mia. E così ho letto in questo sito la poesia “Il tedio di dio” e questa poesia, e anche altro. Allora, ho capito il perché DI QUELLE PAROLE DI DISCREDITO SULLA SUA PERSONA E SULLA SUA OPERA, lei è un poeta troppo grande per la ristrettezza mentale e culturale di quelle persone e, in genere, dei letterati medi che si occupano di poesia.
Volevo solo testimoniarLe questo mio umile pensiero, le poesie che ho letto non sono agevolmente dimenticabili, in un modo o nell’altro si imprimono nella memoria, non è facile scacciarle di lì, non saprei spiegarle perché, altri illustri commentatori lo hanno detto meglio di come potrei dirlo io.
Un cordiale saluto da un Suo ammirato lettore.
trascrivo questo messaggio giunto alla mia email da parte di Laura Canciani:
Caro Giorgio,
ho pensato a lungo a questa poesia così misteriosa e sibillina e sono giunta alla convinzione che tu voglia fare dell’esilio una forma stabile di residenza e voglia convertire la prigione della vita quotidiana dell'”Asilo privato dell’Ombra” in una residenza neutra, la residenza dell’immaginario che trionfa sul principio di realtà, una sorta di rivincita dell’opera d’arte nei confronti del mondo. L’opera come Labirinto dalle cento strade e dalle mille porte che si aprono e si chiudono rivelando insospettabili nuove dimensioni (simboliche, atopiche?). Così si spiegano i cancelli chiusi che vengono aperti dai prigionieri del’Ombra, le belve di guardia ai cancelli, i ricordi, simili alle ombre, che vanno disfacendosi, i cartelli posti in alto, così minacciosi con le loro scritte sibilline. Cartelli di pericolo dunque, disseminati ovunque, che lastricano il sentiero che l’esiliato deve percorrere…