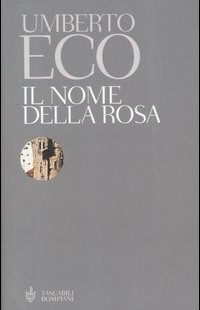
Caro professore Umberto Eco… Verso il trentacinquesimo anniversario de “Il Nome della Rosa”
“Il Nome della Rosa” è un romanzo singolare. Uno su tutti perché linguisticamente appartiene a un certo tipo di letteratura alta, oserei dire colta per molti versi, eppure ha un richiamo fortemente popolare.
In cosa si differenzia Il Nome della Rosa da altri romanzi e thriller avvincenti o meno ambientati in basiliche, chiostri, monasteri? Innanzitutto il primo grande romanzo di Eco è stato l’inizio di una nuova serie di proposte di thriller ambientati fra monaci e antiche abbazie dalla fama maledetta; insomma, una sorta di precursore-prototipo del new gothic, tuttavia la differenza non è solo questa, anzi per farla breve la più importante è quella relativa alla sintesi filologica e culturale che il semiologo compie. Eco, da grande medievalista, ci riporta – aggiornandola – sintassi, luoghi, umori, percezioni, sensazioni che sono sia quelle del medioevo (1300) che di una rilettura moderna, o quantomeno successiva. Noi abbiamo la netta percezione di leggere un romanzo che diviene appunto luogo di concrezione di un sapere vasto e articolato come quello di Eco sul medioevo, e, come sappiamo, la cultura del professore piemontese è davvero abnorme.
Rileggere questo romanzo mi ha fatto tornare in mente un aspetto per me peculiare. Da studente universitario ebbi come docente Umberto Eco, e mi chiedevo spesso qual era la ragione di avercelo come professore, dato che non avevo questo grande interesse sulla sua figura (Eco aveva già pubblicato altri romanzi di successo oltre al primo bestseller) e neanche sui diversi argomenti da lui proposti. Mi domandavo se stavo perdendo qualche buona occasione ad avere un così autorevole mentore e a ignorarlo, ma il mio excursus universitario proseguì senza alcun incrocio con i suoi insegnamenti, se non di sguincio: qualche suo saggio letto, un paio di lezioni, un paio di convegni, un paio di vicinanze al cinema. Poi ebbi una piccola sorpresa, me lo ritrovai nella commissione di laurea, fu presente e attento quando discussi la mia tesi, che peraltro non verteva principalmente su argomenti letterari.
Rileggendo Il Nome della Rosa, mi rendo conto che molti di noi in un certo senso sono nipotini di Eco, per un certo tipo di curiosità intellettuale, per una certa vocazione analitica, esegetica, per un certo gusto del ragionare e del conoscere. Solo ora capisco quanto indirettamente egli mi abbia trasferito, e sia ben lungi da me ogni vanità intellettuale. Mi sento un po’ come Adso, il novizio che ha come maestro Guglielmo; Sean Connery nel film. Intendo semplicemente dire che il prof. attraverso le figure che ne sono state influenzate nell’università, a partire dai docenti, ha trasmesso a noi studenti più di quello che noi allora pensavamo fosse.
La rilettura de Il Nome della Rosa mi ha restituito appieno il professor Eco. Molto interessanti le postille che vanno dalle edizioni dell’83 in poi, dove si parla di problemi e tematiche inerenti alla scrittura, del romanzo come fatto cosmologico. Molti pensano che un intellettuale rigoroso come Eco abbia fatto chissà quale certosina scaletta di avvenimenti nella stesura del suo libro, ma un romanzo, spesso, non è altro che “mobilio”, costruzione di un mondo. Ammobiliate un mondo, conoscendolo, e poi vedrete che in quell’universo popolato di psicologie e personaggi succederanno cose incredibili. Il bello dello scrivere è vedere come la scrittura sia anche scoperta. Ovvio che poi ci siano delle fasi dove si lima, si corregge qualcosa, ma alla base della narrazione c’è la sua cosmologia. Se non si conosce un mondo non ci saranno artifici geometrici che terranno in piedi il libro, che apparirà uno scheletro senza carne.
Vorrei dire di più, dilungarmi, ma la lezione di Eco è anche un insegnamento sulla scrittura come luogo aperto, ipertestuale, dove le intersezioni di senso sono notevoli.
Eco nelle postille esemplifica il tutto anche con l’esempio di due personaggi che dicono una certa cosa simile, nella stessa situazione, eppure questi sono molto diversi fra di loro. Tutto ciò apre la porta a delle analisi o alchimie alcune volte sorprendenti; dei percorsi nel testo che superano le più ardite previsioni, come per esempio scoprire quanto – nel mio modestamente piccolo – io possa essere debitore dello snobbato maestro o rafforzare delle consapevolezze che già erano in me. Del resto l’arte è polisemica per natura, interagisce per vie sconosciute con il nostro vissuto, con una certa idea che abbiamo, con certe aspettative che nella lettura o stesura di un racconto trovano fertilità al posto di altre.
Un’altra considerazione da fare sul romanzo è il concetto del medioevo come epoca dove nasce molto, nasce tutto, dalle banche (ohibò) a una certa idea di culto, di religione, di potere, i comuni per esempio.
Devo dire che un romanzo di questo livello passa per essere un po’ pesante, invece è molto chiaro, e l’uso della punteggiatura e lo schema dei dialoghi del tutto cristallini. E’ una fama immeritata quella di una certa pesantezza, forse dovuta al fatto che il libro ha girato in strati della popolazione non particolarmente avvezzi alla lettura.
Pesantezza che però trova giustificazioni in opere successive (mi perdoni prof!), dove Eco a mio avviso disperde il flusso narrativo in barocchismi intellettuali, citazioni, rimandi, glosse, senza peraltro che determinate tesi proposte risultino poi del tutto convincenti. Il Pendolo di Foucault poi ha un triste primato internazionale: è il testo dove maggiore è lo scarto fra libro acquistato ed effettivamente letto. Ciò la dice lunga sul grado di emancipazione intellettuale di una parte dei lettori, i quali dovrebbero fare scelte più personali.
Un’ultima cosa che va assolutamente detta riguarda il concetto di tempestività editoriale (non ricercata in questo caso), cioè che il romanzo esce nel 1980 in un contesto dominato da una certa letteratura minimale, seppur di qualità, dai gialli, da alcune provocazioni, da un certo dinamico edonismo, da un immaginario post anni settanta ma fortemente vitale, ancorato a una società italiana, quella di quegli anni (gli anni ottanta), in cui aumentano vertiginosamente l’associazionismo, il volontariato, le librerie, la voglia di uscire, di comunicare, viaggiare, divertirsi. L’impegno nei partiti diventa qualcosa da “matusa”, da guardare con apparente distacco (in particolare è aliena la politica parlata e spettacolarizzata di questi anni), ma la società vive nel culto degli incontri e degli scambi. Internet è ancora lontano e i telefonini non esistono. Il fantasy è una nicchia, il thriller uno spazio editoriale come un altro (ora in relativo declino) e i vampiri sono pochi e generalmente in questo caso si va sul classico. Io ero un ragazzino e il top era “Il gabbiano J. Livingston”, perché era breve, non rubava tempo al pallone, agli amici, alle ragazze e ai libri di scuola. In questo contesto Il Nome della Rosa diviene quasi una novità per argomenti. Oggi che non c’è abbazia in cui non ci sia un mistero, un convento dove non ci sia un assassino, una basilica dove non sia nascosta una misteriosa pergamena, un romanzo di tal fatta rischierebbe di avere un richiamo minore, mentre l’uso della lingua, le descrizioni, i dialoghi sono una suprema e letteraria sintesi dell’Eco medievalista. Se il romanzo è un fatto cosmologico non c’è dubbio che poter ammobiliare un mondo come il medioevo di Eco non è affatto facile, ed è anche per questo che Il Nome della Rosa rimane fondamentalmente una pietra miliare nel suo genere.
Per il trentacinquesimo anniversario del suo romanzo Eco aveva pensato di rivedere il testo, esemplificandolo. No, sarebbe una pessima idea. In questo senso i libri successivi si potrebbero più ragionevolmente prestare a un’operazione del genere, se proprio egli volesse riprendere qualcosa…

